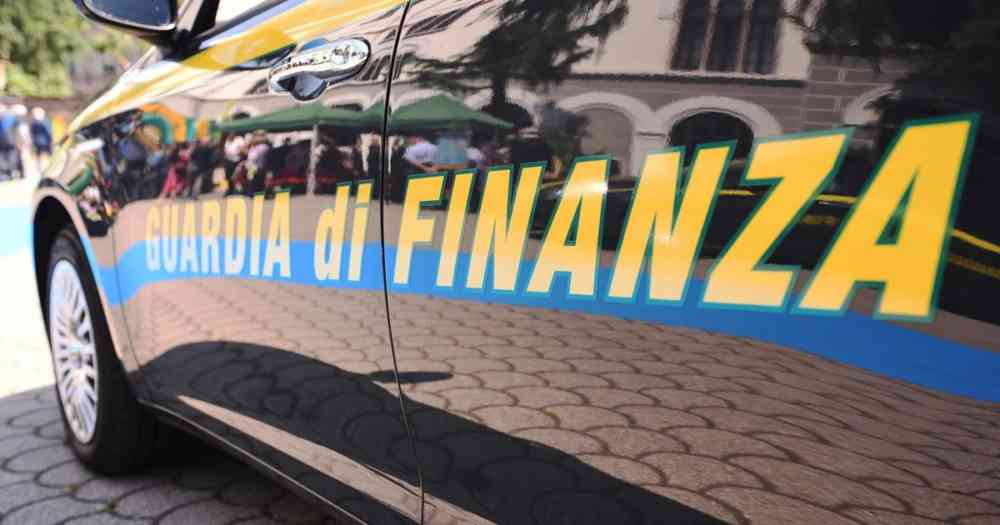Una impresa a rischio usura su 3 è al Sud. A Roma, Milano, Napoli e Torino le situazioni più critiche
Sarebbe dovuto essere l’anno del rilancio post pandemico, degli investimenti e di mutui e finanziamenti concessi a cuor leggero. Invece, per motivi fin troppo tristemente noti, è cambiato radicalmente lo scenario. E più l’economia tossisce, meno le Banche sono propense a concedere prestiti, più cresce il numero di PMI e aziende che, per non chiudere, ricorrono a figure poco raccomandabili. Sono 146 mila le imprese italiane che sono concretamente a rischio usura. Attività che attualmente danno lavoro a circa 500 mila addetti. Si tratta prevalentemente di imprese artigiane, esercenti/attività commerciali o piccoli imprenditori che sono “scivolati” nell’area dell’insolvenza e, conseguentemente, sono stati segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Di fatto, questa “schedatura” preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito. A denunciarlo è l’Ufficio studi CGIA.
“Per i destinatari di questa misura – sbottano dall’Associazione di artigiani – è come se fossero stati condannati alla “morte civile”; un istituto giuridico diffuso in Europa fino al XIX secolo che al condannato comportava la perdita di tutti i diritti civili e il conseguente allontanamento dalla società. Ricordiamo, infatti, che chi è schedato presso la Centrale dei Rischi difficilmente può beneficiare di alcun aiuto economico dal sistema bancario, rischiando, molto più degli altri, di chiudere o, peggio ancora, di scivolare tra le braccia degli usurai”.
Per evitare che questa criticità si diffonda, la CGIA continua a chiedere con forza il potenziamento delle risorse a disposizione del “Fondo di prevenzione dell’usura”, introdotto con la legge n° 108/1996 che ha cominciato a operare nel 1998. Questo fondo è stato introdotto per l’erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi oppure a Fondazioni e Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Strumento, quest’ultimo, in grado di costituire l’unico valido aiuto a chi si trova in questa situazione di vulnerabilità. E’ bene ricordare che gli imprenditori che “finiscono” in questa black list della Banca d’Italia non sempre lo devono a una cattiva gestione finanziaria della propria azienda.
Nella maggioranza dei casi, ricordano sempre da Mestre, questa situazione si verifica a seguito dell’impossibilità da parte di molti piccoli imprenditori di riscuotere i pagamenti dei committenti o per essere “caduti” in un fallimento che ha coinvolto proprio questi ultimi. E’ comunque doveroso segnalare che nell’ultimo anno il numero complessivo delle attività segnalate alla Centrale dei Rischi è sceso di oltre 30 mila unità. Questo lo si deve, in particolar modo, all’attività di “prevenzione” innescata dalle significative misure pubbliche di garanzia e dalla moratoria dei debiti per le Pmi introdotte in Italia dal 2020 per contrastare la crisi pandemica che ha aumentato notevolmente lo stock complessivo dei prestiti erogati alle attività produttive. Queste iniziative sono state più volte prorogate. Da ultimo, fino al prossimo 31 dicembre, data oltre la quale, il differimento potrebbe terminare definitivamente.
A livello provinciale, si legge nel report dell’Associazione degli artigiani, il numero più elevato di imprese segnalate come insolventi si concentra nelle grandi aree metropolitane. Al 31 marzo scorso, Roma era al primo posto con 12.118 aziende: subito dopo scorgiamo Milano con 8.179, Napoli con 7.199, Torino con 5.320, Firenze con 3.252 e Salerno con 2.987. Le province meno interessate da questo fenomeno, invece, sono quelle che, in linea di massima, sono le meno popolate: come Belluno (con 253 aziende segnalate alla Centrale Rischi), Sondrio (246) e Aosta (197) (vedi Tab 1). Se analizziamo i dati per ripartizione territoriale ci accorgiamo che l’area più a “rischio” è il Sud: qui si contano 50.751 aziende in sofferenza (pari al 34,8 per cento del totale), seguono il Centro con 36.026 imprese (24,7 per cento del totale), il Nordovest con 35.457 (24,3 per cento del totale) e infine il Nordest con 23.798 (16,3 per cento del totale).